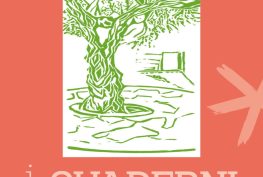PSICOANALISI E NEUROSCIENZE: QUALE MEMORIA CON QUALE COSCIENZA?
_________________________________________________________
Antonio Imbasciati
Professore Emerito dell’Università di Brescia, è membro ordinario e didatta della Società Psicoanalitica Italiana (SPI) e dell’International Psychoanalytical Association (IPA).
Il seguente articolo è la trascrizione della lezione tenuta da Antonio Imbasciati nell’aprile del 2016 presso la Scuola di specializzazione in psicoterapia del Ruolo Terapeutico di Milano. Era invitato all’incontro Pierluigi Sommaruga. Si ringrazia la dottoressa Greta Casiraghi per la trascrizione.
Innanzitutto ringrazio lo staff del Ruolo Terapeutico per avermi invitato a parlare. L’invito era già avvenuto nel settembre scorso da Sergio Erba. Io non conosco voi e quindi non so se quello che vi dirò risulterà troppo difficile o troppo scontato, quindi, nell’uno o nell’altro caso interrompetemi. Ho nominato Sergio, che era stato mio compagno di università, poi dopo la laurea ci eravamo persi, pur sapendo che perseguivamo due strade simili e parallele e cioè quelle della psiche. Poi mi ero ritrovato con lui la fine dell’estate scorsa, il resto lo sapete meglio di me.
Voi avete letto, Neuroscienze e teoria psicoanalitica, libro che ho scritto insieme a Loredana Cena e che tratta del rapporto tra la psicoanalisi e le neuroscienze. Quel libro è stato scritto tre-quattro anni fa (Cena, Imbasciati, 2014), successivamente ho sviluppato il mio pensiero ulteriormente, in altri tre libri. Cercherò di farne una sintesi che tenga conto della base di partenza, quale emerge dal libro che avete letto, di quello che è stato lo sviluppo del mio pensiero.
L’argomento “psicoanalisi e neuroscienze” sarà sempre più interessante in tutto il mondo psicoterapeutico, perché lo stesso oggetto viene visto da due facce diverse: la metodologia delle neuroscienze parla un linguaggio che a tutti gli psicoanalisti e psicoterapeuti risulta difficile e spesso ostico e spesso dà la percezione che si tratti di cose diverse. C’è molto interesse, e ci sono molte controversie, tra gli psicoanalisti e i neuro-scienziati, circa l’opportunità o la necessità di integrarsi; molti psicoanalisti si interessano, come me, alle neuroscienze e pensano che possa avvenire una integrazione, altri dicono che la psicoanalisi è altra cosa che deve rimanere altro. Il punto su cui ci si incontra è “ma a cosa servono le neuroscienze agli psicoanalisti, o agli psicoterapeuti di impostazione psicoanalitica?”
Una piccola premessa per dire che questo problema aveva già interessato Freud: la sua scoperta clinica del beneficio dell’interpretazione sulla sintomatologia disturbante lo condusse alla scoperta fondamentale che esiste qualche cosa che il soggetto in coscienza non pensa e che avviene dunque al di fuori della sua coscienza: da questa scoperta proseguì con un “perché” neurologico che poi abbandonò, per concentrarsi sul “come”. E cioè: “come mai c’è questo qualcosa che lavora al di là della coscienza dell’individuo?” Ci deve essere un lavoro del cervello che non corrisponde per nulla a quello che l’individuo nella sua consapevolezza vive e capisce. Freud non si fermò qui, cercò di scoprire come questo qualcosa – inconscio – potesse essere spiegato nel cervello: cercò di ipotizzarlo con le nozioni che al suo tempo si potevano avere sul funzionamento cerebrale (Freud, 1895). Questo iter va ricordato in quanto è un iter metodologico che è esso stesso “scoperta” (Imbasciati, 2013 a,b), cioè lo stretto legame tra mente e cervello, una cosa che allora costituiva una novità. Freud non riuscì nel suo progetto, la neurofisiologia di allora non gliene dava i mezzi e lo abbandonò ma oggi si ripropone, con una massa di conoscenze del tutto più precisa. Sono passati centotrenta anni.
Freud, non riuscendo a indagare come il cervello lavorasse e come producesse questa mente non cosciente, si concentrò allora su un “come” anziché su un “perché” neurologico e ipotizzò una sua teoria, la teoria energetico-pulsionale, con i concetti di pulsione e di rimozione. Questa teoria è servita alla diffusione della metodologia psicoanalitica, della tecnica clinica, e la sua impronta è rimasta in quasi tutte le psicoterapie. Oggi però viene messa in discussione: qualche psicoanalista pensa che possa essere ancora utile, intesa in senso metaforico come aiuto alla comprensione di quanto accade nel paziente, io penso che non sia più utile, e che vada messa nell’archivio della storia di quella scienza che si chiama psicoanalisi. Però questa teoria, come tutte le teorie, è servita per fare andare avanti la pratica, cioè la clinica. Questa, nel suo progresso, è servita a mettere in dubbio non pochi aspetti e utilizzi della teoria ipotizzata da Freud. In genere una teoria serve a far progredire una prassi e il progresso di questa prassi può a sua volta condurre a riformulare la teoria, o a ipotizzarne una nuova. Così accade in tutte le scienze. Una teoria è sempre un’ipotesi, e Freud ha sempre riconosciuto che la sua concezione energetico-pulsionale fosse un’ipotesi, anzi nella sua tarda produzione la chiamò “la Strega” (Imbasciati, 2013a). Sono convinto che in cuor suo fosse contento che la teoria energetico-pulsionale avesse segnato il successo della psicoanalisi, anche se non la condivideva più, altrimenti non l’avrebbe chiamata così ironicamente, ma preferì tacerne, per favorire la promozione della psicoanalisi nel mondo.
Vediamo come e perché e con quali scoperte delle neuroscienze e anche della psicologia sperimentale dobbiamo abbandonare questa teoria pur riconoscendone i meriti. È questa la stessa strada che tentò Freud centotrenta anni fa nel suo Progetto di una psicologia (1895), che oggi possiamo ritentare con mezzi diversi. Inizierò parlando di memoria.
Credo che sappiate che da tempo si distinguono varie forme di memoria. Le principali sono quelle per cui si distingue una memoria dichiarativa, che si può tradurre in parole e che è perfettamente cosciente; una memoria semantica, che è cosciente ma che non è molto descrivibile se non con circonlocuzioni di parole; una memoria di riconoscimento, quando cioè si riconosce qualche cosa che si è già visto e udito e che prima di riconoscerlo non eravamo consapevoli di ricordare, e ancora si distingue una memoria di lavoro: quella che riguarda tutte le successive operazioni automatiche, che sono necessarie per compiere un certo lavoro, qualunque azione quale si fa sempre nella vita comune, dove ci muoviamo intelligentemente per compiere tutta una serie di azioni parziali (es. prendere una certa cosa, metterla in un posto, chinarsi, camminare, sedersi ecc.) senza che ne siamo consapevoli, ma delle quali abbiamo memoria, altrimenti saremmo del tutto scoordinati e incapaci. Collegata a tal tipo di memoria, si è distinta la memoria procedurale, riferendosi alla memoria della coordinazione motoria che noi adulti abbiamo per fare qualsiasi cosa. Questa memoria è molto evidente nei bambini piccoli: il bambino impara a gattonare, poi a stare eretto, ha acquisito una memoria di come muovere i suoi muscoli. Non possiamo essere consapevoli della nostra coordinazione motoria, dunque siamo già nel non consapevole, visto da una prospettiva non psicoanalitica.
Si è visto che questa memoria procedurale va oltre l’aspetto motorio e si è parlato di memoria implicita, ampliando di molto il concetto. Ci sono delle posture e delle mimiche che sono motorie, ma hanno un contenuto psichico: noi con i nostri occhi, con la nostra faccia, parliamo, “diciamo”, esprimiamo qualcosa, e di questo di solito non siamo consapevoli. A volte facciamo uno sforzo per celare che ci venga fuori una qualche espressione mimica che potrebbe essere sgradevole all’interlocutore, facciamo finta: la piena consapevolezza è solo nel fare finta, altrimenti c’è qualche cosa di ben poco consapevole che viene fuori spontaneamente.
A seguito della teoria dell’attaccamento si è parlato inoltre di modelli operativi interni, strutture di comportamento o meglio di condotte, anche di tipo cognitivo, che riguardano il modo con cui una persona è e agisce. Questo può talora coincidere con ciò che nel nostro lessico va sotto la parola di carattere. C’è una memoria implicita di pensare, agire in un certo modo individualissimo. Il carattere non viene dai cromosomi, per via genetica: da quando siamo nati questo carattere viene costruito, si dice “forgiare il carattere”. In realtà si tratta di apprendimenti, inconsapevoli, che rimangono come memoria implicita. C’è poi la struttura affettiva, ognuno ha la sua, è qualcosa che sta dietro al carattere, per così dire.
C’è dunque una memoria di affetti – questa è una delle più recenti acquisizioni – una memoria inconsapevole per cui in noi si attivano determinati affetti, anche senza esserne coscienti, a seconda delle situazioni. La nostra struttura affettiva non può non essere stata memorizzata. Se abbiamo una certa affettività, vuol dire che abbiamo una memoria di come e quando nelle varie occasioni si dispiega la nostra struttura affettiva. Questa memoria non è consapevole, non la possiamo “ricordare”, e spesso neppure descrivere, la dispieghiamo a nostra insaputa in modo automatico a seconda delle varie nostre interazioni. Poche volte ci accorgiamo di provare qualcosa.
Vi ho parlato di memoria in questo modo, per farvi capire che la memoria è molto diversa dal ricordo: noi facciamo una grande confusione tra la memoria e ciò che possiamo ricordare, e la gran parte della nostra memoria non la possiamo ricordare. Questo introduce il rapporto tra memoria e coscienza, e anche il concetto stesso di coscienza. Che cos’è la coscienza? Se fate caso a tutti gli esempi di memoria che vi ho elencato, non è che in alcuni casi ho perfetta lucida coscienza, e in altri casi assolutamente no, ci sono gradi intermedi, e allora è sbagliato continuare a usare il termine “la” coscienza. La coscienza non è una qualità specifica, una dimensione on/off, ma è un quantum, variabile nel tempo (nonché in ogni singolo) e in funzione di che cosa riguarda. Abbastanza facile è capire se siamo o no coscienti quando consideriamo ciò che chiamiamo “pensiero”, un ricordo concreto, una convinzione; meno facile è accorgersi di quanto un sentimento ci sia o meno presente. Dobbiamo parlare di “capacità” di coscienza. Questo è frutto di alcune scuole psicologiche non psicoanalitiche. In Italia, Liotti (1994), un cognitivista, ha diffuso nei suoi libri questo concetto, mutuato da altri studi (Gilbert, 1989), in cui mostra che ci sono vari gradi di coscienza: ogni individuo ha la sua specifica capacità di coscienza e questa capacità di coscienza varia da momento a momento e a seconda di con chi si sta. È quindi la coscienza una capacità fluida, variabile da individuo a individuo e a seconda delle situazioni. Con un certo amico voi capite qualche cosa di voi stessi, acquisite una certa coscienza di voi stessi, che prima non avevate, o che, interagendo con un’altra persona, non si manifesta. Un contatto interpersonale particolare vi può far aumentare in quel momento la vostra capacità di autocoscienza.
Oggi un illustre scienziato ci dimostra come una gradualità di coscienza si dispieghi anche per gli animali, più limitata di quella degli umani, più variabile, ma hanno anche loro un grado di coscienza (Panksepp, 1999). Se voi frequentando una certa persona avete un certo sentimento, per esempio di interesse, di apprezzamento, o di antipatia, questo sentimento è già una piccola rudimentale forma di una qualche coscienza, magari sbagliata.
Non esiste dunque la coscienza, ma la capacità di coscienza, variabile da individuo a individuo e nello stesso individuo variabile a seconda del momento e delle circostanze soprattutto interpersonali. Usare termini come “la” coscienza, “prendere” coscienza, o anche “essere coscienti” tradisce a mio avviso la presenza in noi del coscienzialismo ereditato dalla nostra tradizione filosofico-religiosa dell’occidente.
Nella considerazione della memoria la nostra tradizione fa sì che noi ancor oggi pensiamo che la memoria sia ciò che si ricorda, mentre invece ciò che si ricorda è una piccolissima parte della nostra memoria; e spesso sbagliata. Può capitare che un amico riscontri che oggi ricordate una cosa che invece il mese scorso ricordavate diversamente: si dice allora nella nostra cultura corrente che c’è un deficit di memoria. Ma questo proviene dal considerare la memoria uguale al ricordo! La memoria non è il ricordo. Se noi non ricordiamo una cosa, si dice che si ricorda male, ma perché male? Chi l’ha detto che la memoria debba essere stabile? Vi anticipo la scoperta delle neuroscienze attuali: la memoria, di qualunque tipo sia, cambia in continuazione, di conseguenza e ovvio che possa cambiare il ricordo. Memoria è un concetto psicofisiologico, ricordo è invece un concetto psicologico, il primo si riferisce a cosa fa il cervello, il secondo ne è un “qualche” effetto, di coscienza appunto, che può essere del tutto difforme di volta in volta. Il nostro fondatore della psicoanalisi italiana, Cesare Musatti, prima di dedicarsi alla psicoanalisi aveva studiato la psicologia della testimonianza, dimostrando come in buona fede una testimonianza può cambiare, dopo un mese, o rispetto alle circostanze gestaltiche di come la si percepì (Musatti, 1931). Noi invece continuiamo ad avere la concezione della memoria coincidente con il ricordo e parliamo di un deficit di memoria ancora oggi come se fossimo ai tempi di Ebbinghaus (1885), che voleva studiare la memoria senza concetti, senza associazioni. Se vi esaminate, riscontrate che avete ancora questa idea fuorviante, che la memoria debba essere stabile. E se cambia? Come mai? E qui cascò lo stesso Freud: prese in considerazione il fatto che in certi casi traumatici la memoria cambiava, e ne fece un grande interrogativo con ipotesi di spiegazione, da cui nacque un fiume di letteratura, sul cambiamento di memoria – la famosa Nachtraglichkeit – a mio avviso inutile oggi, perché, casomai, si dovrebbe spiegare come mai in qualche situazione la memoria rimanga stabile.
Dietro queste idee, c’è un’altra idea sottintesa, che fa da forma al nostro modo di ragionare e di essere, e cioè che la nostra mente, o forse il nostro cervello, sia come una sorta di video-fono-registratore. Niente affatto, non è un video-fono-registratore, non registra niente. C’è anche sottointesa l’idea che nei nostri neuroni si fissino le immagini, i ricordi… no assolutamente no: oggi le neuroscienze hanno dimostrato che la memoria non è una fissazione di una realtà esterna dentro un qualcosa del cervello che poi ha le sue influenze sulla “mente”. La memoria è il lavoro di miliardi di reti neurali che continuante si attivano e si disattivano, talvolta si estinguono, e ciò che conta non è il neurone ma la rete neurale, le sinapsi. Quindici anni fa LeDoux disse la famosa frase “noi siamo le nostre sinapsi” (1999), oggi si parla di “connectoma” per indicare l’insieme delle connessioni (Seung, 2013). Come si formano questa connessioni? Si formano per apprendimenti. Cerchiamo di dimenticare che l’apprendimento sia qualcosa di simile a quello scolastico: apprendimento è già quando un feto al 5° mese di gravidanza riconosce un determinato suono oppure no. A livello neurale vuol dire che si sono formate alcune reti che gli permettono una memoria di un riconoscimento di un certo suono; per esempio del battito cardiaco materno; così pure il neonato appena partorito riconosce l’odore del capezzolo materno. Questo vuol dire che nel suo cervello è avvenuto qualcosa che gli ha fatto imparare che quello è l’odore della mamma.
Picasso diceva che dipingeva come pensava che un neonato vedesse il mondo: provate a pensare con questo esempio a come un neonato di tre-quattro giorni debba “vedere” la realtà; non assemblata nel modo in cui abbiamo imparato ad assemblarla noi. Nella nostra corteccia vengono infatti ad essere costruite reti neurali che ci permettono di organizzare le afferenze periferiche della retina: queste afferenze, oltre a una prima organizzazione lungo le vie ottiche e il mesencefalo, più integralmente sono assemblate in corteccia, in modo da dare quel risultato – la percezione – che noi adulti diamo per scontata, naturale e automatica. Questa progressiva organizzazione e le relative reti neurali che progressivamente vengono costruite, devono invece essere imparate. Certi bambini fanno più fatica ad imparare a percepire e “vedranno” più a lungo la realtà in modo simile a quella che vedono i neonati o i bimbi di qualche mese. Oltretutto non si tratterà soltanto di imparare ad organizzare le afferenze visive, ma a coordinarle con quelle motorie e auditive. Un neonato che si mette a piangere per un rumore improvviso –noi diciamo “perché ha paura” – in realtà non ha ancora completamente organizzato le sue reti neurali in modo che producano quello che più tardi potrà esser chiamato paura, con le relative reazioni, bensì più semplicemente piange perché non riconosce quello che aveva imparato a riconoscere quando non c’era il rumore.
Il neonato che si spaventa per un viso estraneo, non è che gli faccia paura l’estraneo, è che non riconosce più quella faccia che ha imparato a riconoscere. È l’angoscia, molto più primitiva, del non avere ancora imparato, l’angoscia di non sapere, di non conoscere. Il bambino piange perché sta chiedendo aiuto, perché qualcuno gli ”insegni” cosa sia quella nuova realtà, affinché qualcuno – direbbe Panksepp – aiuti il suo seeking.
Qui noi siamo schiavi del vecchio concetto di maturazione neurologica: il termine “maturazione”, che di solito implica un processo biologico, naturale, viene impropriamente applicato allo sviluppo neonatale e perinatale: maturano le mele, non il cervello. Quest’ultimo deve imparare i programmi funzionali che gli permettano di “conoscere” progressivamente la realtà: a cominciare dal sapere come guardare gli occhi della mamma, dal sapere poi come si fa ad afferrare un affarino colorato che gli pende davanti, ad imparare a gattonare, poi a camminare, a riconoscere non soltanto il volto della mamma ma anche altri volti oltre quello materno. Noi siamo schiavi del più semplice concetto di una maturazione per natura: più difficile è pensare al complicato, progressivo imparare a come si organizza la capacità di percepire, e poi di riconoscere il percepito. C’è anche una maturazione intesa in senso proprio, ma avviene nell’embrione e nel feto, e nei primi giorni del neonato che si esaurisce, surclassata sempre di più dall’apprendimento che comincia negli ultimi mesi della gestazione e che esplode, per così dire, durante i primi diciotto mesi di vita extrauterina. Si tratta di apprendimento delle funzioni che permettono la percezione, e poi una conoscenza, che restano come memoria in reti neurali: questa memoria è stata imparata, costruita nel cervello attraverso connessioni neurali.
Cito qui gli studi di una scienziata italiana, da trent’anni negli Stati Uniti, Cristina Alberini (2013), che ha studiato sperimentalmente sui ratti cosa succede quando si stabilisce (costruisce) una memoria, piuttosto che quando questa memoria non avviene, o quando avviene che una nuova esperienza modifichi una memoria precedente. La scoperta che sta sotto queste ricerche e che sta interessando gli psicoanalisti, grazie anche al fatto che Cristina Alberini oltre essere una biologa scienziata ha fatto anche un training psicoanalitico, è che a seconda del momento emozionale si verifica nel cervello un fatto particolare, e cioè certe afferenze sensoriali che giungono dalle vie sensoriali, producono una stimolazione del DNA genico che produce delle catene proteiche, le quali vanno a formare nuove sinapsi. Parlando di ratti, il momento emozionale che risulta idoneo a costruire memoria viene misurato biochimicamente: è l’arousal dell’organismo e quindi di certe reti neurali. Questi esperimenti vengono trasferiti in questi ultimi tempi all’umano: è il momento interumano particolare, emozionale che non deve essere né troppo forte né troppo debole, il giusto momento che fa sì che succeda l’evento biochimico che genera le proteine che vanno a formare delle nuove sinapsi, nuove reti neurali: e questo ad ogni nuova esperienza che avvenga nel giusto livello emozionale. Questo è di estremo interesse per gli psicoanalisti, per capire quello che fa cambiare il paziente. Ogni nuova rete neurale che si forma, si integra con le precedenti, quindi il funzionamento globale delle reti presenti in un certo momento nel cervello varia man mano che vi sono nuove esperienze che producono nuove reti neurali.
La memoria varia perché è data dall’insieme delle reti neurali che, di volta in volta, possono mettersi in atto, per esempio nel nostro comportamento, nel nostro modo di pensare, nel nostro umore, nell’affetto che potremmo avvertire in un certo momento. È memoria di modi con cui funzioniamo a seconda delle circostanze, che siamo in grado di conoscere e collegare (neuralmente, si intende, cioè inconsapevolmente) con precedenti esperienze. Tutto questo lo si vede bene seguendo lo sviluppo del feto e del neonato: il bambino ha bisogno del giusto livello emozionale per imparare, e questo rapporto emozionale non dipende soltanto da lui, ma dipende dalla coppia che in quel momento sta interagendo. E qui, chi si occupa di bambini, si trova facilitato a seguirne il progresso. Nel neonato c’è un dialogo di segni, di messaggi – per cui il bambino impara o non impara e se non impara di solito piange in quanto non capisce – che procede soprattutto nei momenti di incontro.
Perché alcune volte le mamme non riescono a sintonizzare con il bambino e questo bambino piange? Spesso con la buona volontà cercano di distrarlo, ed è la peggiore delle cose, e il bimbo piange ancora di più, finché tacerà: è gran brutto segno per il suo futuro psichico, in quanto significa che il bimbo ha imparato che non bisogna cercare di capire. Altro esempio: spero che le mamme che hanno bambini piccoli, le giovani fra i trenta e i quarant’anni, siano tutte delle buone mamme, però capita spesso che una mamma non sia in grado di calmare il suo bambino, mentre la nonna sì: perché è capace di parlare senza parole, è capace di intendersi con il piccolo. C’è un dialogo, di cui si sono occupati molto due autori Beebe e Lachmann (2003), che parla dei “momenti di incontro” che sono decisivi per l’apprendimento del bimbo e dei momenti di rottura, anche di madri più attrezzate, ma che poi si possono recuperare. Tutto dipende da quante rotture e da quanti recuperi avvengono. Il momento di incontro corrisponde al giusto livello emozionale (arousal) che fa costruire nuove reti neurali.
Tutto questo ha delle riscontranze visibili con la risonanza magnetica del cervello. I primi esperimenti risalgono all’inizio del 2000 (Schore, 2003 a,b): nella risonanza magnetica della mamma che allatta il suo piccolo, si vede una concordanza delle due risonanze magnetiche quando il dialogo è sintonico, rispetto a quando è asintonico, quando ci si intende rispetto a quando non ci si intende. Quando ci si intende vuol dire che si costruiscono memorie, che il bambino impara, che si costruiscono reti neurali che saranno custodi di un modo particolare che il bambino ha imparato e che gli servirà da base per ogni ulteriore apprendimento. Lo sviluppo potrà essere buono o meno buono – si può anche imparare a non imparare – a seconda di una sufficiente corrispondenza di significati e significanti emessi dalla madre. A seconda della qualità dei significati trasmessi dalla madre, queste comunicazioni non verbali contengono messaggi che si strutturano in memoria e formano i primi rudimenti della mente del bambino, durante gli ultimi mesi della gestazione, e soprattutto durante i primi diciotto mesi di vita, quando il bambino non parla ancora ma impara da una comunicazione non verbale i primi modi per capire la realtà (Cena, Imbasciati, 2014; Imbasciati, 2016a).
Credo risulti chiaro che questa prima cognizione è una cognizione che chiameremmo affettiva: oggi i neuro-scienziati dicono che tutto il lavoro del cervello è un lavoro emozionale, e che la cognizione è un piccolo non sempre presente risultato, talvolta cosciente e talvolta, pur essendo cosciente, ingannevole, di tutto un precedente ininterrotto lavoro emozionale del cervello. La psicoanalisi aveva scoperto l’ingannevolezza della coscienza cento anni fa: questo concetto è oggi enormemente ampliato.
Cito qui quanto è stato chiamato “alessitimia”: alcuni adulti hanno poca capacità di avvertire cosa sentono loro o cosa sentono anche gli altri, per esempio persone che arrossiscono senza accorgersi di aver avuto un’emozione; altre invece sono molto sensibili. Chi è sensibile a capire cosa gli sta succedendo, è anche più sensibile a capire cosa sta succedendo ad altri con cui sta interagendo. Alcune persone sembra che non siano capaci: sono state chiamate alessitimiche. Si è ritenuto che si trattasse di una patologia: i successivi studi hanno chiarito che tale sindrome non è una qualità on/off, bensì una dimensione continua della quale in un primo tempo erano apparsi casi estremi. In realtà ogni persona ha di più o di meno la capacità di capire cosa gli succede dentro e cosa succede nel suo interlocutore. Questo continuum è una dimensione che si struttura a cominciare dal neonato. In casi estremi si è considerato l’autismo, in cui ancora non si sa quanto ci possa essere una predisposizione genetica, o quanto epigenetica: ma sicuramente c’entra il dialogo neonatale con il caregiver; tanto più che esistono sindromi variabili di autismo, maggiori minori, più o meno accentuate. C’è poi da considerare che nel dialogo non c’è solo la capacità della mamma nel dialogare con il bimbo e quello che il bimbo sta imparando, ma anche quello che il bimbo ha imparato prima di cominciare il dialogo extrauterino. Conta anche il dialogo intrauterino e tale iniziale dialogo fonda un iniziale reticolo di reti neurali che sono quelle che poi lavoreranno l’esperienza successiva.
L’esperienza non è costituita dalle afferenze che provengono dall’esterno, ma quella per cui le afferenze che provengono dall’esterno sono state elaborate, attraverso quello che possono elaborare in quel momento le reti neurali di quel neonato. Ci sono quindi una serie di effetti a cascata, progressivi, che determinano l’individualità del cervello di ciascuna persona. Nessuno ha un cervello uguale a quello di un altro (Magistretti, 2002), nemmeno i gemelli omozigoti, perché in utero hanno esperienze differenti. C’è anche da contare che la mamma, capace o non capace, deve avere il tempo e la serenità sufficiente per dialogare fruttuosamente con il suo bimbo, e qui dallo psicologico entriamo nella sociologia: quanto la nostra società permette, come tempo a disposizione, ad un caregiver di occuparsi di un neonato?
La conclusione è che tutto il cervello è memoria, indipendentemente da quanto si possa ricordare, e che il ricordo è una piccolissima parte della memoria, che le reti neurali sono quelle che conservano la memoria; ma che le reti neurali non funzionano tutte allo stesso modo e tutte insieme, volta a volta ne funzionano alcune e poi altre.
–
Domanda: Lei ha detto che la memoria non coincide con il ricordo, e ha parlato di deficit di memoria ma non inteso come deficit del ricordo. Mi chiedo quanto consenso ci sia su questa cosa perché lavorando in RSA con gli anziani, tutta la valutazione cognitiva del deficit di memoria è effettuata in base al ricordo che un paziente ha, quindi…
Imbasciati: In effetti ciò che si fa e che si prescrive di fare è molto parziale, bisognerebbe che nei Servizi si protocollassero altre tecniche, per esempio di osservazione del comportamento. Ci sono tanti casi particolari – qui Pierluigi Sommaruga potrebbe citarli meglio di me – in cui, a seguito di certe lesioni, l’individuo per esempio non vede ma è come se vedesse. Così pure può comportarsi nella vita quotidiana come se avesse in memoria tutte le varie operazioni che occorre fare in giusta sequenza, senza però che le possa “ricordare”.
Sommaruga: C’è anche un aspetto importante che ci interessa particolarmente come operatori clinici ed è quello del contenuto della memoria. Leggevo un libro, L’impostore, che racconta di questo personaggio spagnolo, Marco, che si inventa una sua storia ma lui si immedesima anche nel personaggio, ed è una memoria che lui racconta che si modifica nel tempo rendendosi più adatta. In un certo modo noi sappiamo che la storia clinica che ci racconta un paziente, l’autobiografia, è una costruzione il cui contenuto varia continuamente. Sappiamo che la memoria funziona, ma funziona anche modificandone il contenuto, modificandone il ricordo e generalmente quando il funzionamento è ottimale, l’aggiornamento è sempre più consistente in relazione al luogo, al tempo, alle relazioni e ai vissuti di quel momento. L’aggiornamento continuo della storia permette di inventare nuove storie più adeguate al benessere mentale, al benessere razionale; poi non sempre funziona così… a volte diventa disfunzionale. È come se tanti nostri pazienti imparassero che i ricordi vanno loro bene, che le storie vanno loro bene, per se stessi ma anche per raccontarle al loro prossimo. Il vissuto, nel momento stesso in cui parliamo, sta modificandosi, sta calibrandosi portando piccole sfumature proprio perché è in relazione con un “noi” che fa una certa professione, che ha un certo atteggiamento, quindi la realtà con cui dobbiamo confrontarci è estremamente fluida.
Imbasciati: C’è un bellissimo film abbastanza recente, di cui non ricordo il nome, di un aguzzino di un lager nazista che alla fine della guerra, all’ultimo momento, per sfuggire alla vendetta era riuscito a fingersi uno degli ebrei internati nel lager. Emigrato in America con questa identità l’aveva dovuta conservare a lungo, continuando a fingere di essere quell’ebreo, finché pian piano si era convinto di essere proprio quello, tanto da andare alla ricerca dell’aguzzino suo persecutore, per scoprire alla fine che questi era proprio lui.
Sommaruga: È un esempio di sopravvivenza, si presentava in un certo modo anche a se stesso.
Domanda: Nutro il sospetto che le neuroscienze, un certo tipo di approccio, possano in qualche maniera diminuire o vanificare gli sforzi dell’analisi. Mi conforta sentirvi dire invece delle cose che, proprio seguendo l’onda e il discorso che lei ha fatto, fortificano invece ancora di più il significato della nostra relazione con un paziente, aiutando il nostro mestiere di analisti.
Imbasciati: La nostra struttura affettiva, attrezzata da tutta la nostra esperienza analitica, modifica la struttura affettiva del paziente perché, al di là delle interpretazioni verbali che noi possiamo dare, c’è qualcosa che da noi emana, qualcosa che il paziente coglie, e lo elabora in modo che la sua struttura affettiva e la relativa traccia mnestica, cioè la relativa memoria si va a modificare. In analisi ci sono i momenti di incontro dove abbiamo la sensazione che qualcosa stiamo riuscendo a cambiare: c’è qualcosa di questa situazione emozionale, nel corso della terapia, che fa sì che si stabiliscano delle nuove sinapsi. E quindi il patrimonio delle miriadi delle reti neurali di quella persona, si arricchisce di qualche rete neurale in più, e allora si spera che questo migliaio di reti neurali in più del momento terapeutico, faccia sì che altre reti neurali si rallentino o si estinguano. La globalità delle reti neurali segna il cambiamento terapeutico.
–
Domanda: La relazione terapeutica intesa così, non è più solo fantasmatica… è questo che ci sta dicendo?
Imbasciati: Il fantasma c’è sempre, è una realtà essenzialmente psichica, il cui concetto ci serve come stazione intermedia tra quello che succede nel cervello e quello che noi possiamo capire con la nostra capacità di coscienza. Certamente questi discorsi sembra che indeboliscano il concetto dell’interpretazione psicanalitica come unico ed essenziale e appropriato, ma non lo indeboliscono a mio avviso: ma dicono che l’interpretazione verbale dell’analista è un cavallo sul quale cavalca un qualche altro cavaliere; si spera portatore di vita e non di distruzione.
Ora, siccome qualcuno mi ha chiesto degli altri libri oltre a questi due che ho qui mostrato, vi accenno ad un altro, che si intitola Dalla strega di Freud alla nuova metapsicologia, per dirvi come è importante che, con l’aiuto delle neuroscienze, gli psicoanalisti riformulino una nuova metapsicologia, senza aver paura di offendere la memoria di Freud (che comunque rimane un grande genio), così come io per mio conto ho fatto e proposto ai colleghi nei miei libri: una nuova metapsicologia (Imbasciati, 2013b; 2015). Alcuni psicoanalisti si arrabattano per ricondurre tutto a Freud e questo a volte può essere fuorviante. Molte delle mie proposizioni nel formulare la mia nuova metapsicologia provengono dalle neuroscienze, ma anche dalle altre scienze della mente e soprattutto dalle discipline che si sono occupate di studiare i bambini piccoli. La Psicologia Clinica Perinatale che io coltivo a Brescia fino dagli anni ’90 è una sintesi di come la psicoanalisi infantile, la teoria dell’attaccamento e altri studi hanno dato origine a quel filone che si chiama Infant Research, una psicologia sperimentale applicata che usa sia i contributi della Psicologia Generale sia quelli psicoanalitici. L’Infant Research può essere agevolmente integrata con le neuroscienze (Imbasciati, 2016).
La riflessione che vorrei portare a questo punto è sullo sviluppo neuro-mentale dal feto al bambino. È uno sviluppo del cervello, per tutto quello che impara un neonato. Dobbiamo però considerare anche quanto impara un feto: qui le cose sono meno evidenti e la ricerca è più difficile.
Penso che tutti, direttamente o indirettamente, abbiate avuto pratica di cosa è un neonato, di cosa è un bimbo nei primi diciotto mesi di vita, di quante cose impara, che noi attribuiamo al “cervello normale”. Nella nostra cultura c’è il pregiudizio dell’idea del “cervello normale”, cioè di un apparato cerebrale che per natura (genetica) fa tutto quello che riteniamo grosso modo esser “normale”: in realtà nella maggior parte della gente il cervello ha imparato quelle funzioni che permettono di agire adattativamente alla vita quotidiana degli umani; si tratta di una media standard di apprendimenti di funzioni. In realtà il “cervello normale” per natura non esiste: la genetica dell’homo sapiens determina la macromorfologia del cervello, ma la micromorfologia e la fisiologia conseguente sono frutto dell’esperienza, cioè di apprendimenti, o di espressività genica anch’essa acquisita. Il cosiddetto cervello normale, pensato tale per natura, è un ideale perché è comodo pensare che la natura ci abbia dato un cervello normale: abbiamo così forte il sentimento di essere consapevoli di noi, di conoscerci, di determinarci, di essere liberi, di avere “la” volontà, che ci è difficile (angoscioso?) pensare che tutti lo abbiamo imparato e che questo apprendimento ha costruito il nostro individuale cervello; pensar tutto questo evoca responsabilità, senso di colpa poiché sotto sotto pensiamo comunque che “potevamo” fare diversamente e, per chi conosce un po’ come impara un bimbo piccolo, si ribaltano colpe sui propri genitori; anche questo ci fa soffrire.
Siamo soliti notare i mutamenti macroscopici degli apprendimenti dopo che il bambino impara a parlare, perché con le parole ci fa capire le sue operazioni mentali, però c’è tutta una gran massa di funzioni che ha imparato prima e che, se non le avesse imparate prima, non potrebbe neanche imparare a parlare. Impara a guardare negli occhi la madre e poi gli altri, a percepire, a riconoscere. Soprattutto a percepire: ma sapete davvero cos’è la percezione? E che la si acquisisce per gradi, lungo i primi mesi di vita? Se noi non avessimo imparato bene a percepire, cioè ad assemblare nel giusto modo le differenti afferenze delle diverse sensorialità, io che sono seduto e che quindi ho le natiche che mi premono sulla sedia, potrei confondere questa afferenza che è continua e che il mio cervello recepisce continuamente, con quella di stare lì a vedervi. Risultato? “Vi vedo col sedere”. Sono sensorialità diverse, eppure il nostro cervello le assembla per avere una percezione intelligente, ma anche le tiene separate. Un neonato tutte queste cose non le ha imparate ancora e quindi, se gli fa male la pancia, questa afferenza viscerale può essere confusa con l’afferenza visiva del volto della mamma. Risultato? La mamma mi fa male dentro la pancia. Un residuo di questa capacità di assemblare si ha nella persecutorietà, quando in una situazione psicopatologica persecutoria tendono ad essere unite afferenze che vanno tenute separate e si confondono afferenze esterne diverse tra di loro con “prodotti interni”, pensieri, sentimenti, idee.
Parliamo allora di come la mente umana si sviluppa in quanto viene a costruirsi il cervello. Viene a costruirsi perché ogni nuova esperienza, produttivamente o distruttivamente, viene a creare delle reti neurali che si integrano con le precedenti. La realtà esperienziale non è tanto l’esperienza esterna che va ad essere registrata nel cervello, è quanto il nostro cervello elabora da tutte le informazioni che ci vengono sensorialmente dalla realtà esterna e da quella corporea; questa elaborazione dipende da quello che in quel momento il nostro cervello è capace di elaborare, di assemblare o di tener separate tutte queste varie afferenze. Quando si parla di esperienza, si parla di esperienza fatta dal cervello, non dell’esperienza tal quale si potrebbe fotografare dall’esterno, ma di un’esperienza interiore. Qui possiamo fare un aggancio psicanalitico al Bion di “apprendere dall’esperienza”: non si impara l’esperienza, si impara “da” (from) ciò, meglio “per” ciò che il nostro cervello è capace di fare di tutte le informazioni che riceve dall’esterno e dal suo funzionamento, nonché dal funzionamento di ogni organo del nostro corpo, che a doppia via è collegato col cervello di ogni nostro organo.
Faccio un inciso per ricordarvi un bel libro di Porges, La teoria polivagale (2014), in cui dice che il neonato ha un sesto senso che l’adulto perde, e cioè che il nervo vago, che in medicina viene studiato come un nervo efferente e regolatore, è in realtà un nervo afferente, e nel neonato ha una grossa integrazione con quello che può fare la parte superiore del cervello. Il neonato ragiona con ciò che il suo nervo vago trasmette.
Già vi ho parlato dell’Alberini, del livello di stress sperimentato sugli animali, del giusto momento di incontro; di qui l’importanza del caregiver e di converso l’importanza dello psicoterapeuta. Le interpretazioni sono i veicoli sui quali passa qualcosa che cambia, l’emozione, che in sé è ineffabile. È questo incontro emotivo continuo che modifica la strutturazione del nostro cervello. Allora tutto questo ci rende, come psicoterapeuti, psicoanalisti, cauti nel dire “ho capito… e interpreto”. Già alcuni analisti hanno parlato del timing nell’interpretazione, della temperatura (mi sembra sia Meltzer che parla della temperatura), cioè del momento in cui l’analista può valutare che è efficace l’intervento, altrimenti o non serve a niente o è nocivo. Tutto quello che sappiamo dalle neuroscienze ci rende ulteriormente cauti all’interpretare quando ci sembra di aver capito: l’interpretazione è ciò che la coscienza dell’analista, la capacità di coscienza di quell’analista in quel momento riesce a pensare con le parole, ma tutto il resto del cervello dell’analista che sta facendo? E quindi quell’interpretazione è un lavoro di coscienza, di un analista in un certo momento di un incontro. O meglio un momento in cui l’analista pensa che sia avvenuto un incontro. Si pensa che con l’interpretazione si sveli l’inconscio: in realtà l’interpretazione è un lavoro di coscienza dell’analista che va alla coscienza del paziente. Quando è utile?
Di qui l’importanza del dialogo non verbale. Anche per gli adulti. Quali significanti usiamo? Non è facile coglierlo. Significanti sono tutte le espressioni corporee sensoriali su cui viaggiano i significati della madre e del bambino reciprocamente, dell’analista e dell’analizzando, ma quali significati? Non possiamo dire quali significati perché per dirlo dovremmo verbalizzarli, e tali significati sono meramente emozionali Quali codici emaniamo noi in psicoterapia e come questi codici vengono decifrati dal cervello del paziente in quel momento, che cosa ne ricava, che ne resta? Lo vediamo nella psicoterapia, con più evidenza lo vediamo nel dialogo con il neonato. I significati sono emessi inconsapevolmente, e non sappiamo neanche quali sono: sappiamo che il bambino li recepisce diversamente a seconda di come in quel momento lavora il suo cervello, a seconda del momento di incontro o di rottura. È difficile per noi fare un salto mente-cervello, perché la nostra mente cosciente ci dice solo quel che appare dicibile, ma null’altro di cui non sappiamo niente, o ben poco capiamo.
–
Domanda: Per fare questo salto di cui lei parla, difficile per le neuroscienze, entra in soccorso la psicoterapia. Il pericolo che percepisco è che le neuroscienze possano ingannevolmente proporsi come risolutive o interpretate in tal modo. Invece la psicanalisi è quasi necessaria per poter sfruttare questo salto, proprio perché non tratta il materiale cosciente ma si propone di interrogare e indagare tutto quello che è difficile sapere, e non conoscibile e quindi non si propone come sapiente di qualcosa come le sinapsi, ma come ignorante rispetto a qualcosa.
Imbasciati: Le neuroscienze non sostituiranno mai la psicoterapia, però che l’analista abbia in mente cosa le neuroscienze gli dicono su come funziona il cervello è importante.
–
Domanda: Il pericolo che percepisco io personalmente è che siano i neuro-scienziati a non avere presente l’importanza dello scambio psicoanalisi e neuroscienze. Sarebbe auspicabile che ci fosse uno scambio reciproco…
Imbasciati: Ci sono dei neuro-scienziati che pensano di andare avanti solo con le loro tecnologie, pensano che andando avanti solo con queste si possa fare molto meglio e quindi disprezzano anche la psicanalisi. Per contro ci sono psicoanalisti che disprezzano le neuroscienze, pensano che la psicoanalisi debba andare avanti come è, propinano che la psicanalisi sia autonoma. Si tratta di una disparità di opinioni con i pericoli dall’una e dall’altra parte. Credo che uno psicoterapeuta psicoanalitico debba avere in mente come funziona il cervello e lasciare che questa conoscenza delle neuroscienze lo renda semplicemente più attento a cosa gli sta succedendo, lo renda vigile a sapere quello che gli sta accedendo.
Qui potremmo fare una parentesi su come questi eventi siano fondamentali in tutti i mammiferi: cominciando dagli invertebrati, e poi un salto con i vertebrati e un secondo salto quando dai rettili si passa agli uccelli, il terzo salto è quando si passa ai mammiferi, e di salto in salto ai primati e all’uomo. Ci sono reti neurali preformate, uguali per tutti i mammiferi, situate nel tronco cerebrale e che reggono sette sistemi motivazionali che Panksepp individua come dettate da uno specifico principio: per esempio “cercare protezione per la miglior sopravvivenza”. Centrale in questi sette sistemi è quello che è chiamato “il seeking”, cioè la tendenza/motivazione a cercare, per poi imparare a scegliere che cosa ci è utile e che cosa ci è dannoso. Altra tendenza motivazionale è la rabbia e l’aggressività quando ci si trova aggrediti; poi esistono la predisposizione neurale del sistema della paura, del sistema dell’accoppiamento, e quella del gioco (Panksepp, 1998, Panksepp, Biven, 1012). Non so se le ho dette tutte: questi concetti li ritrovate nei libri citati.
Avere in mente le neuroscienze vuol dire tenere conto di ogni comunicazione che va al di là delle parole e quindi della nostra coscienza: spero che in un futuro gli psicoterapeuti possano essere adeguatamente formati a tenere conto della comunicazione non verbale. Fino ad adesso la psicoanalisi ha raccomandato di non usare il canale corporeo per comunicare, ma solo per ascoltare se stessi e poi tradurre questo in qualche interpretazione (controtransfert). Ha raccomandato per esempio di non maneggiare il paziente, ed è una giusta cautela, perché, se uno non è attrezzato, chissà dove può andare. Ci sono contatti corporei distruttivi, lesivi: quelli etichettati come erotici facilmente possono essere distruttivi. Ma c’è qualcuno che dice che, siccome funzionano anche le terapie corporee, massaggi, rilassamenti e altro potrebbero essere adeguatamente usati. Chissà se, nel futuro, non ci potremmo attrezzare anche con questi mezzi, sapendo evitarne i pericoli.
Vorrei tornare un attimo a riassumervi i principi che riguardano lo sviluppo neuropsichico e la formazione relazionale della mente, cominciando dal bambino, o meglio dal feto e dal neonato. Ogni funzione biologica è modulata dal cervello, oggi così si intende la psicosomatica, come studio di questa modulazione, non semplicemente per lo studio delle malattie psicosomatiche; le malattie psicosomatiche sono state gli esempi che ci hanno insegnato che esiste anche la regolazione neuromentale continua di ogni organo del nostro corpo; prima ho citato Porges con “la teoria polivagale”. Qui il concetto collima con quello di Damasio, neuroscienziato che dice che il cervello continuamente esegue una mappa del proprio corpo e dello stato di esso stesso cervello, una mappa che cambia continuamente (Damasio, 2010). Quando vi parlavo di quello che impara il bambino nei primi mesi dopo la nascita, parlavo di come egli impara un rudimentale senso di sé, qualcosa che gli dice che esiste, e che poi, andando avanti sarà, prima “bimbo fa”, “bimbo dice”, poi sarà “io faccio”, “io dico”, “io penso”. Questo sentimento non tutti lo hanno sviluppato nello stesso modo. Questo senso di esserci e di essere noi, cambia da persona a persona.
Ogni funzione del nostro corpo è modulata dal cervello, il genoma determina la macromorfologia del nostro encefalo e alcuni nuclei contenenti reti neurali preformate, ma tutta la micro morfologia, cioè le sinapsi, è acquisita dall’esperienza. L’esperienza non è quello che accade obiettivamente, ma quello che il nostro cervello viene a costruire e ricava da tutte le informazioni che riceve. L’esperienza per l’homo sapiens è massima a livello interpersonale: anche per tutti gli altri mammiferi è interpersonale, tutti i mammiferi hanno dei contatti, chi più e chi meno. C’è una bellissima fotografia sul libro, Affective neuroscience (Panksepp,1999), di uno scimpanzé con il suo piccolo. Contano i primi diciotto mesi di vita.
Ogni minimo particolare di qualunque nostra condotta dipende dalla struttura che si è creata nel mente-cervello, a cominciare dalla formazione di quelli che Damasio chiama “i sentimenti primordiali”, qualcosa di né consapevole né di assolutamente inconsapevole, qualcosa che qualcuno può anche avvertire in parte, o in maniera distorta, o che non può avvertire affatto, ma che esiste; e corrisponde a quelle mappature che Damasio ha studiato. Noi siamo succubi del concetto che la mente coincida con l’intelligenza, che è la parola più vaga che esista: anche se la precisiamo con la parola cognizione, non facciamo altro che apporre un grosso filtro a questa parola, intelligenza. Per fortuna oggi si parla anche di intelligenza emotiva, e questo meglio si avvicina ai dati delle neuroscienze: il 95-99% del nostro cervello lavora con un lavoro emozionale, poi una piccola parte passa quel filtro di coscienza che funziona in quel momento in quel soggetto e diventa cognizione. C’è un continuo lavoro del cervello, di cui non sappiamo quasi nulla: siamo suscettibili di ingannarci, e ci aggrappiamo a certe concezioni tradizionali, avvertendo la novità come un pericolo; ma la novità è sempre un pericolo, qualsiasi cosa che non conosciamo può essere pericolosa.
Ma cos’è l’emozione? Facciamo differenza tra l’aggettivo “emozionale” e l’aggettivo “emotivo”: ci serve per differenziare che emozionale è tutto, tutto il cervello-mente, ed è quel tutto di cui siamo quasi completamente inconsapevoli; qualche volta avvertiamo l’emozione, e se la avvertiamo troppo ci diciamo “emotivi” ma emozionali siamo sempre. Anche se non ci sentiamo emozionati.
Altra nozione da tenere presente nell’evoluzione dello sviluppo neuromentale dell’individuo è che agli inizi della costruzione del cervello, il funzionamento è tutto del cervello destro, fino a tutto il primo anno di vita: il bimbo impara con il cervello destro, poi si inizia ad attrezzare anche il sinistro e attrezzandolo si attrezza anche la rete di connessioni tra destro e sinistro. La sperimentazione neurologica, da lunga data, ci ha dimostrato quanto sia importante avere due cervelli connessi. Fino a un anno/anno e mezzo di vita si può considerare che il bimbo funzioni solo con il cervello destro: questa priorità emozionale del cervello destro, per la sopravvivenza della stessa vita, ci dà da pensare a quanto noi siamo spesso troppo “sinistri”. Fino all’alessitimia.
Vi ho già parlato del concetto di connectoma (Seung, 2013): cambia in continuazione. Si suol dire “se ti funziona il cervello, se sei normale”, questo denuncia la concezione errata e grossolana di cui già abbiamo parlato: il cervello cambia in continuazione e noi non ce ne accorgiamo, e ci sembra che il mondo sia sempre lo stesso. In tale continuo cambiamento spicca la relazionalità, con passaggio continuo di informazioni, emanate da due o più persone in interazione; anche se se ne stanno immobili e senza parlare. Cosa spicca in questa dimensione relazionale che sfugge alla nostra capacità di coscienza e che è quello che forgia in continuazione gli individui l’uno con l’altro? Spicca il modo con cui il cervello di ognuno elabora la continua informazione che riceve. Questa elaborazione è frutto di ciò che fino a quel momento è stato costruito. Elaborazione è ciò che il cervello è capace di trasformare di ciò che riceve.
Questo comincia quando il cervello inizia a funzionare: allora bisogna considerare il neonato e il feto; a seconda di come i primi funzionamenti, le prime reti neurali si sono costruite, queste avranno la loro incidenza su come ogni possibile esperienza sarà elaborata e quindi come con nuove reti neurali integrate con le precedenti potrà essere integrata quella capacità di elaborazione di quell’individuo. Si ha così un progressivo effetto a cascata multiplo. Di qui l’importanza delle prime costruzioni: qui consideriamo la capacità genitoriale, che tutti gli psicoterapeuti dovrebbero avere il più possibile attrezzata, perché più o meno tutti i nostri pazienti hanno avuto dei genitori con mediocri o cattive capacità genitoriali. Con loro è cominciato il primo circolo vizioso, le prime reti neurali non ottimali e l’elaborazione non ottimale delle successive esperienze, anche buone ma elaborate male; sono questi effetti a cascata quello che gli psicoterapeuti si arrabattano a curare. Ma devono essere migliori genitori.
Dobbiamo avere una buona capacità genitoriale, questo ci interessa come psicoterapeuti ma credo ci debba coinvolgere anche come individui umani che hanno costruito la società e la civiltà. Qui si apre un interrogativo su come sarà questa capacità genitoriale nella media degli individui che si occuperanno di bambini. Oggi aiutiamo questa dimensione genitoriale a svilupparsi nelle future generazioni? O la deprimiamo? O la stiamo deprimendo nella struttura sociale in cui avvengono i nostri contatti? È con i nostri contatti che si strutturano le nostre menti. Ho l’impressione che stiamo andando verso una riduzione delle possibilità che un individuo acquisti buone capacità genitoriali perché i suoi bambini siano un pochino meglio di lui. C’è il rischio che le circostanze saranno tali che i suoi bambini saranno un po’ meno di lui: e le successive generazioni? La transgenerazionalità, e non soltanto l’intergenerazionalità, passa attraverso la catena delle strutturazioni medie della media delle strutturazioni dei cervelli che verranno. Di qui si evince l’importanza che chi di queste cose, come noi, ne sa qualcosa, ne tenga conto anche nella possibilità di incidere sul sociale, affinché si pensi al futuro. Quale transgenerazionalità attenderà i nostri figli, i nostri nipoti?
Sommaruga: Prendo un piccolissimo esempio… la storia del bambino che piange, il bambino piange e che mamma si ritrova? Una mamma affettuosa che cerca di calmarlo o la mamma spaventata e angosciata? Mi viene in mente un episodio raccontato da una collega pediatra. Arriva da lei una madre accompagnata dal marito e dal bambino e le dice “il bambino piange quindi è malato”, la pediatra lo visita e dice che il bambino è sano, la madre dice che però piange tutta la notte. E allora che cosa c’è dentro questo bambino? Nella sua memoria implicita c’è “un terrore senza nome”, è l’esperienza di angoscia senza fine e non so come lo potremo curare. Ci chiediamo anche che cosa trasmetterà un bambino con queste esperienze un domani ai suoi figli? Che maturità avrà di elaborare il dolore, di elaborare il dolore dell’altro? Sono situazioni che ci fanno pensare a che eredità stiamo lasciando ed è da questo pensiero importante che dobbiamo confrontarci poi con la nostra esperienza quotidiana.
Domanda: Ieri una collega in supervisione mi porta una situazione clinica in cui c’è un giovane paziente (25/30 anni) che nel proseguo della terapia gli fa vedere una certa ferita sul collo che il padre gli avrebbe procurato quando era molto piccolo. Questo contenuto emerge verso la fine della seduta e la terapeuta mi dice che congedandolo gli fa una carezza su questa ferita aggiungendo qualcosa come “credo sia ancora aperta”. L’intento della terapeuta è lenitivo, incontrante; io da parte mia invece ho avvertito tutt’altro, ho avvertito un atto più che irrispettoso, anche un po’ sadico. Talmente divaricante tra quello che ho percepito io e le intenzioni del terapeuta, che non ho avuto il coraggio di dirle questa cosa. Volevo una sua lettura a proposito…
Domanda: Quando lei parlava prima della relazione madre-bambino, io pensavo proprio alla relazione terapeutica, dove si utilizza la parola, ma la stessa parola è simbolo e mediatore di altri significati. Penso che il nostro corpo ci sia sempre e ci sia comunque anche quando pensiamo di non usarlo…
Imbasciati: Avete chiesto tutti delle cose alle quali non è possibile dare una risposta precisa: c’è sempre la questione del corpo e il corpo viene avvertito diversamente da ognuno. Rispetto al paziente con la ferita sul collo, io non credo si possa dire chi ha ragione, quello che si può dire è che magari sbagliate entrambi. Poi l’altro intervento, l’imbarazzo di fronte a queste prospettive è perché non siamo attrezzati: usiamo ancora degli attrezzi molto rudimentali perché sono sicuri, perché ci siamo abituati ad usarli, perché facciamo meno errori. Certamente ci sono degli altri strumenti, ma che cosa ci succederà non lo so, non credo che si possa dare risposta, certamente questa capacità genitoriale la dobbiamo sviluppare il più possibile sia nella nostra professione, sia nella nostra vita privata, e aver cura che magari le nuove generazioni possano essere anche guidate, per poter usare questo qualcosa, di cui noi ci sentiamo più sicuri nelle relazioni intime e private, anche nelle relazioni meno intime.
Sommaruga: Vi racconto un piccolo episodio che molti di voi conoscono. Mi viene inviato un ragazzo in terapia con problemi di crisi di angoscia. È la seconda volta che ci vediamo, siamo in fase preliminare, e mi racconta che il giorno prima era in metropolitana, ha avuto una crisi di panico, ed è caduto a terra come svenuto. L’hanno soccorso, è tornato a casa ma ha paura che si ripresenti una crisi così, a un certo punto, cominciando a rievocare questa crisi, comincia a respirare affannosamente ed a agitarsi sulla sedia, ad un certo punto comincia ad urlare “il cuore mi sta cedendo, sto morendo chiami un’ambulanza”. A questo punto mi protendo verso di lui, una mano la metto sulla fronte e con l’altra gli prendo il polso, è stato un gesto automatico. Gli tengo un breve e autorevole discorso dicendo “no, è soltanto la sua mente che manda segnali al cuore, il suo cuore sta bene, si sta calmando…” e la crisi passa. È stato il primo e unico intervento fisico che ho fatto in tutta la successiva terapia, che aveva un senso, perché noi sappiamo che il nostro sistema vagale è collegato alle vie superiori, quindi questo ragazzo stava perdendo la vista, quindi non riceveva più informazioni sull’aspetto fisico degli altri, sulla mimica, e mancando di informazioni, non gli era possibile modulare il suo sistema vagale, quindi questo inviava potenti segnali al sistema simpatico e succedeva una crisi di immobilizzazione di panico in cui lui cadeva al suolo, e in altri momenti, una crisi di panico vera e propria. A me avevano insegnato tantissimi anni fa gli infermieri del reparto in cui lavoravo in pronto soccorso… se una persona aveva una crisi isterica, ponendogli un dito sugli occhi, la crisi isterica cessava.
Domanda: Rispetto a quello che diceva di Freud, mi sembra che una intuizione ancora valida sia quella della struttura associativa della nostra mente che si basa sulla rete delle connessioni. Questa rete però molto elastica, cambia in continuazione… mi chiedevo però quale può essere il perno attorno al quale tutta questa rete associativa si costruisce perché, in qualche modo, anche se cambiamo continuamente, rimane un tempo di noi che ci fa sentire unici e mi chiedevo se, anche per le neuroscienze, esiste un perno su cui tutto questo ruota e fa sì che se anche il sistema cambia però rimaniamo comunque unici e stabili.
Imbasciati: Lei pone l’accento sul fatto che in uno sviluppo migliore, le cose vengono organizzate intorno a un qualche perno che ci fa sentire che noi siamo sempre noi; senz’altro tutto questo come tutto quanto può succedere nel nostro mente- cervello, dipende da come lavora e lavorava. Credo che Freud avesse un po’ in mente tutto questo, per quello che ne poteva sapere. Lei parla di associazioni, possiamo dire la “rete associativa”, ma non sappiamo meglio specificare il significato della parola “associazioni”, visto che si tratta di miriadi e miriadi di connessioni che funzionano mutevolmente. Poi col suo concetto di associazione mi fa pensare al concetto opposto, alla scissione, e come qui storicamente ci sia la diatriba con Janet e Piaget. Freud ha parlato di scissione ma ha preferito continuare ad elaborare la sua teoria energetico-pulsionale trascurando un po’ il come nella mente si possano riscontrare in qualche modo delle non associazioni che possono essere più o meno accentuate finché certe parti della mente vengono dissociate.
–
Domanda: Ha parlato di sviluppo relazionale, di capacità genitoriale, però anche di una parte innata nel bambino. Come si conciliano queste due cose nello sviluppo della relazione tra il bambino e la mamma?
Imbasciati: Questa parte innata la si constata soprattutto percorrendo la scala zoologica degli animali e dei mammiferi in particolare: dal modo in cui questa struttura innata può variare nell’homo sapiens. Per progressive continue integrazioni in altre strutture costruite, dipende da come il funzionamento di questa struttura innata potrà cercare (seeking) e trovare (genitorialità?) il contatto corporeo. Nei mammiferi superiori questa capacità di contatto, questa necessità di contatto corporeo, è evidente: però quello che constatiamo esaminando l’etologia lungo la scala dei mammiferi è che c’è sempre una maggiore integrazione del funzionamento, dai mammiferi inferiori ai primati, con ciò che, man mano che si sale nella scala zoologica, le varie specie hanno la possibilità di imparare. Man mano che c’è a disposizione una maggior massa neuronale (corticale) c’è più possibilità che il funzionamento dei nuclei innati comuni a tutti i mammiferi venga variato, arricchito, modulato. Quanto poi da qui si possa passare all’ultima parte del suo discorso, la responsabilità di un caregiver e quella del suo bimbo, direi che certamente sono due che lavorano insieme, e che c’è da contare anche l’esperienza prenatale, sulla quale sappiamo pochissimo. Che cosa si è strutturato durante la gestazione nel cervello di questo feto? Sappiamo soltanto che quando arriva al quinto mese di gravidanza questo feto è capace di discriminare e di riconoscere dei suoni. Ma prima non sappiamo niente, non sappiamo quanto in quei suoni che il feto al quinto mese sa discriminare, c’è un precedente lavoro (protostrutturazione?) del cervello, che possa deporre per una precedente elaborazione di esperienza, se c’è stato qualcosa prima.
Di quello che succede al terzo/quarto mese di gravidanza sappiamo pochissimo: non so come si possa parlare di responsabilità del bambino. Attenzione poi a non scambiare questo concetto che lei ha chiamato responsabilità con il concetto di colpa. La responsabilità implica una causalità, che peraltro ci risulta confusa, mentre il senso di colpa è tutt’altro. Troppo spesso si colpevolizzano le madri e i padri.
–
Domanda: Volevo che mi aiutasse a capire meglio un fatto che è accaduto in una relazione con un mio paziente. Questo paziente, bellissimo ragazzo, un atleta, ha avuto un rapporto disastroso con la madre, dominante, minacciosa, che si ritrova un po’ incarnata in alcuni personaggi della vita che gli mettono terrore, senza sapere che richiamano a questo. Questo ragazzo parla di questo evento molto angoscioso con una postura del corpo accasciata, e io dico “senta Roberto se la sente di tirarsi su e di raccontarmi di nuovo cosa ha sentito? È venuta fuori una cosa diversa, i fatti erano gli stessi, ma la tonalità emotiva era completamente diversa, e su questo abbiamo potuto lavorare e stanno succedendo delle cose. Vorrei che lei mi aiutasse a capire cosa è successo, era un’altra persona che raccontava gli stessi avvenimenti, era cambiato il corpo ma anche l’emotività.
Imbasciati: Penso che posso darle una ben scarna spiegazione, ma certamente questi fenomeni non sono strani, e quindi ci riconducono a questa unione corpo-mente, che ci scompiglia: assumere un assetto muscolare diverso ha avuto qualche influenza sul suo cervello.
Il lavoro che compie il cervello è sempre sia su quanto fa esso stesso sia su quello che gli arriva dal corpo. Ad un certo punto lei ha innescato una specie di circuito per cui il paziente ha modificato il corpo e questa modifica ha avuto un feedback sul funzionamento neurale globale.
–
Domanda: Ti vorrei porre questa questione… non c’è un rischio, un pericolo di una sorta di deriva di tipo cognitivo comportamentista?
Imbasciati: Vi ho parlato dei pericoli di ogni novità di cui non abbiamo fatto sufficientemente esperienza e di cui non siamo attrezzati: possiamo e ci possiamo fare del male. Il pericolo c’è, e d’altra parte ci sono dei momenti fortunati in cui ci è scappato qualcosa che poi forse a posteriori abbiamo sentito che era salutifera.
Mi è sempre rimasto nella mente la scena visiva di una mia paziente sulla porta in uscita: io le feci una carezza sul braccio – io tra l’altro non ho l’abitudine di dare la mano all’entrata e all’uscita – e quella carezza fece cambiar tutto.
–
Domanda: Lei saprebbe spiegare perché ha fatto quel gesto? Se era consapevole di volerlo fare con un obiettivo?
Imbasciati: Ora non lo ricordo, ricordo soltanto la visione e il ricordo semantico, cioè che è cambiato tutto. Sono convinto che sia stato utile perché ha segnato una svolta, credo che fossimo al quarto anno di analisi.
Ora vorrei riprendere, per concludere, un’ultima cosa: l’eredità che abbiamo tratto da Freud, è quella di una certa rigidità nel setting, per esempio la forte raccomandazione “attenzione agli agiti”, soprattutto agli agiti propri, si intende. L’eredità freudiana ci ha abituato soprattutto a non toccare. Ci sentiamo forse un po’ impacciati: dobbiamo tenere presente il pericolo della novità. Freud ha lasciato queste raccomandazioni, che hanno poi irrigidito i primi setting tra gli anni ’50 e ‘80, però Freud stesso era molto più libero, conversava parecchio: qui riconosco a Freud delle doti di politica gruppale molto oculate per i suoi allievi, che potevano scivolare troppo nelle derive. Oggi che siamo un pochino più liberi qualcuno dice che si scivola nella deriva del comportamentismo, ma le derive ci sono anche nel mare calmo, l’importante è tenerne conto e vedere di utilizzarle al meglio. Tornando a Freud, poi c’è da considerare il fatto che la sua metapsicologia stava avendo successo e che necessariamente egli doveva occuparsi di questa. Viene intitolato “Metapsicologia” l’insieme dei 5 saggi ma in realtà i primi due sono molto diversi dai successivi: il primo e il secondo sono specificamente di una teoria in senso proprio, cioè esplicativa, con l’ipotesi della pulsione e della rimozione. La teoria energetico-pulsionale ebbe grande successo, e tutti si sono buttati a usarla in mille variazioni per spiegare la clinica. La diffusione della psicoanalisi nel mondo è dovuto a questa invenzione teorica.
Però questa invenzione, da dieci anni a questa parte paralizza gli psicoanalisti: Freud l’ha chiamata “la Strega” e in un altro passo l’ha definita “la nostra mitologia” (Imbasciati, 2013). Il mito serve a coagulare gruppi, collettività. Ma la grandiosità di Freud ha indotto i suoi a venerarlo fin troppo, a sentirsi soli se rinunciavano a qualcosa di lui, malgrado egli avesse detto che erano tutte ipotesi. È questo il tema su cui io ho sempre insistito nei miei scritti: la teoria energetico-pulsionale col concetto di rimozione. Freud aveva constatato che certi pazienti mostravano “la resistenza”. Quale ragionamento sta sotto l’ipotesi della rimozione? Che lo psichico avrebbe dovuto diventar cosciente e rimanere cosciente. Lo pensava implicitamente Freud, non ancora completamente uscito, malgrado la scoperta dell’inconscio, dal coscienzialismo che dominava la cultura del suo tempo; e ancora la nostra! Si identifica la mente con quello che la coscienza, quella più lucida, pensa ed esprime con le parole. Con tutta la panoramica dell’inconscio che spero di avervi dato soprattutto nella prima ora, perché mai pensare che l’inconscio debba diventar cosciente? Oggi: ma a quel tempo? Freud ha confuso la resistenza con la rimozione, perché si pensava che ci fosse la “naturale” tendenza verso la coscienza, una forza che spingeva, e pertanto ci doveva esserne un’altra che respingeva. Noi questa rimozione la possiamo oggi spiegare diversamente, in termini di memoria: la memoria che cambia.
La mutevolezza della memoria, che oggi possiamo constatare anche sperimentalmente, può benissimo spiegare perché oggi uno ha un certo tipo di coscienza, e domani un’altra per la quale non può più ricordarsi e quindi nega di riconoscerla nell’interpretazione e non si ricorda più. Ma la memoria c’è, ne è cambiato l’assetto e non c’è ricordo. Nella prosecuzione dell’analisi la memoria cambiata può, nel contatto con l’analista cambiare di nuovo, e far tornare un ricordo, forse non come quello che ricordava l’analista; e comunque far cambiare l’insieme della struttura mnestica del paziente. L’inconscio può essere spiegato come memoria con tutte se sue variazioni e cambiamenti, senza dover ricorrere a una ipotesi come quella della rimozione. Eppure molti analisti ancor oggi pensano in termini di rimozione: questo cosa li induce a fare? Che, se hanno in mente il concetto di rimozione, hanno in mente anche che per il paziente bisogna trovare le interpretazioni migliori per togliergliela. E si sforzano di usare come metafore i concetti di libido, la pulsione, ecc. Ma a che scopo? Un certo uso della metafora cela che, al di là delle convinzioni razionali, si concepisce la mente nei termini concreti che la metafora descrive. E resta implicito, e inconsapevole il presupposto pregiudizio che tutto dovrebbe esser cosciente, e che la mente è “la” coscienza, che la “normalità” è la coscienza. La mente è inconscio, ma non quell’inconscio che crediamo di riconoscere nell’interpretazione: molto di più (Imbasciati, 2016a). A questo proposito sta per uscire un mio articolo sul Giornale Italiano di Psicologia intitolato “L’inconscio come memoria” (Imbasciati, 2016b).
Per poter accogliere le neuroscienze, bisogna non avere il fardello di collegare per forza ciò che ci dicono le neuroscienze con ciò che ci disse Freud. Colleghiamolo alla nostra clinica attuale, a quanto constatiamo spesso essere “l’indicibile” qualche volta si potrà anche risalire alle intuizione freudiane, ma non è necessario dover collegare le neuroscienze a tutto quanto disse Freud. C’è un fardello nel collettivo della ricerca analitica che impedisce di trovare il giusto equilibrio fra come io faccio la mia clinica (senza andar troppo nella deriva materialistica o comportamentistica) e avere in mente come funziona la mente, anche secondo quanto ti dicono le neuroscienze pur continuando ad agire con i mezzi psichici. In questa prospettiva, il collettivo di psicanalisti, psicoterapeuti psicanalitici, sta lavorando per elaborare una nuova metapsicologia che tenga conto non tanto di quella parte della metapsicologia freudiana espressa nei primi due saggi, ma che tenga conto di tutta la clinica, a cominciare da quella nel terzo, quarto, quinto saggio, quando parla del lutto.
La metapsicologia freudiana è quella dei primi due saggi, con le sue ipotesi esplicative (esplicative in senso proprio di una accezione corretta), oggi inutile.
Occorre una nuova metapsicologia, con nuove ipotesi su come funziona la mente per quel che ne sappiamo oggi del cervello. Secondo me, una delle vie per fare questo è studiare meglio la memoria e questo studio può essere aiutato dalle neuroscienze.
–
Domanda: Stavo pensando a questa integrazione corpo-mente e a questa integrazione tra neuroscienze e psicanalisi. Non si può certo ignorare che esistano certe scoperte scientifiche ma mentre parlava pensavo ad altre forme di integrazione tra neuroscienze e psicologia che hanno informato la pratiche psicoterapeute. Il rischio poi non è che si prenda dalle neuroscienze soltanto quell’aspetto della scienza positivista per cui dopo si deve andare a misurare il risultato con metodi specifici, dimostrabili… In America le assicurazioni pagano le psicoterapie in base al fatto che ci siano degli indicatori di risultato… anche nelle nuove disposizioni sanitarie regionali in Italia, gli indicatori di performance e risultato stanno diventando davvero informativi. Il rischio è che ci portiamo a casa gli effetti di controllo delle neuroscienze. È un rischio possibile?
Imbascati: Sì, in ogni cosa bisognerebbe saper scegliere la parte buona.
–
Domanda: Lei dice, possiamo fare a meno in buona sostanza del concetto di rimozione… A me sembra che cadano poi una serie di cose, in primis il sintomo, che nella metapsicologia freudiana è spiegato come un capolavoro fra diverse dimensioni, è una bella soluzione di compromesso riguardo a un conflitto. Faccio fatica a sostituire questo sapere con quello che stai dicendo tu. C’è una relazione fra memoria implicita e costruzione del sintomo?
Imbasciati: Io penso di sì, ma credo anche che bisognerebbe scoprirla paziente per paziente. La legge generale ipotizzata da Freud era che c’era questa pulsione che ha trovato sfogo nel sintomo. È sempre un paragone di spinta-controspinta, col sottointeso che esista la normalità, e che la normalità non sia tanto un funzionamento standard quanto una legge naturale. Un conto è la normalità in senso statistico, e altro conto è intenderla riferendosi alla natura. Siamo abituati a lavorare con un certo schema e l’idea di abbandonarlo ci turba, perché non abbiamo ancora trovato il modo di impadronirci del nuovo schema e tantomeno di tradurlo in una pratica clinica. Credo che ci si muoverà in questo senso. Quando e se ne avremo i mezzi, per vedere meglio cosa succede nel nostro cervello.
Domanda: Immagino che il tuo modo di lavorare sia cambiato in maniera importante…
Imbasciati: Sì, peccato che sia cambiato un po’ tardi, sono vecchio. Ora comunque lavoro meglio vis a vis, per esempio…
Bibliografia
Alberini C. (2013) Memory Reconsolidation, Elsevier, New York
Beebe B., Lachmann E. (2003) Infant Research e trattamento degli adulti, Cortina, Milano
Cena L., Imbasciati A. (2014) Neuroscienze e psicoanalisi, Springer, Milano
Damasio A. (2001) Il Sé viene alla mente, Adelphi, Milano
Ebbinghaus H. (1885), La memoria, trad. Zanichelli, Bologna, 1971
Freud S. (1895), Progetto di una psicologia, O.S.F.,Boringhieri, vol.1
Gilbert M.M. (1989) Human Nature Suffering, Erlbaum, London
Imbasciati A. (1998) Nascita e costruzione della mente, Utet libreria-De Agostini, Torino
Imbasciati A. (2013) Psicoanalisi senza teoria freudiana, Borla, Roma (a)
Imbasciati A. (2013) Dalla Strega di Freud alla nuova metapsicologia, Angeli, Milano (b)
Imbasciati A. (2015) Nuove teorie sul funzionamento della mente: l’istituzione psicoanalitica e gli psicoanalisti, Angeli, Milano
Imbasciati A. (2016) Quindici brevi lezioni di Psicologia Integrata, Alpes, Roma (a)
Imbasciati A. (2016) L’inconscio come memoria e la diffidenza degli psicoanalisti, Giornale Italiano di Psicologia (GIP), XLII, 371-383 (b)
Imbasciati A., Cena L. (2015) Psicologia Clinica Perinatale per le professioni sanitare, Angeli, Milano (tre volumi)
Le Doux C. (1999), Il Sé sinaptico: come il cervello ci fa diventare quello che siamo, Cortina, 2002, Milano
Liotti G. (1994) La dimensione interpersonale della coscienza, NIS, Roma
Magistretti P., Ansermet F. (2004) A ognuno il suo cervello, Boringhieri, Torino
Musatti C.L. (1931) Elementi di psicologia della testimonianza CEDAM, Padova, Rizzoli 1991
Panksepp J. (1999) Affective Neuroscience, Oxford Un. Press
Panksepp J., Biven B. (2011), Archeologia della mente, Cortina, Milano
Porges L. (2014) La teoria polivagale, Fioriti, Roma
Schore A. (2003) Affect disregulation and the disorders of the Self, Norton, New York (a)
Schore A. (2003) Affect regulation and the repair of the Self, Norton New York (b)
Seung H. (2013), Connectoma, Codice, Torino
_________________________________________________________________________________
SCARICA L’ARTICOLO IN FORMATO PDF: